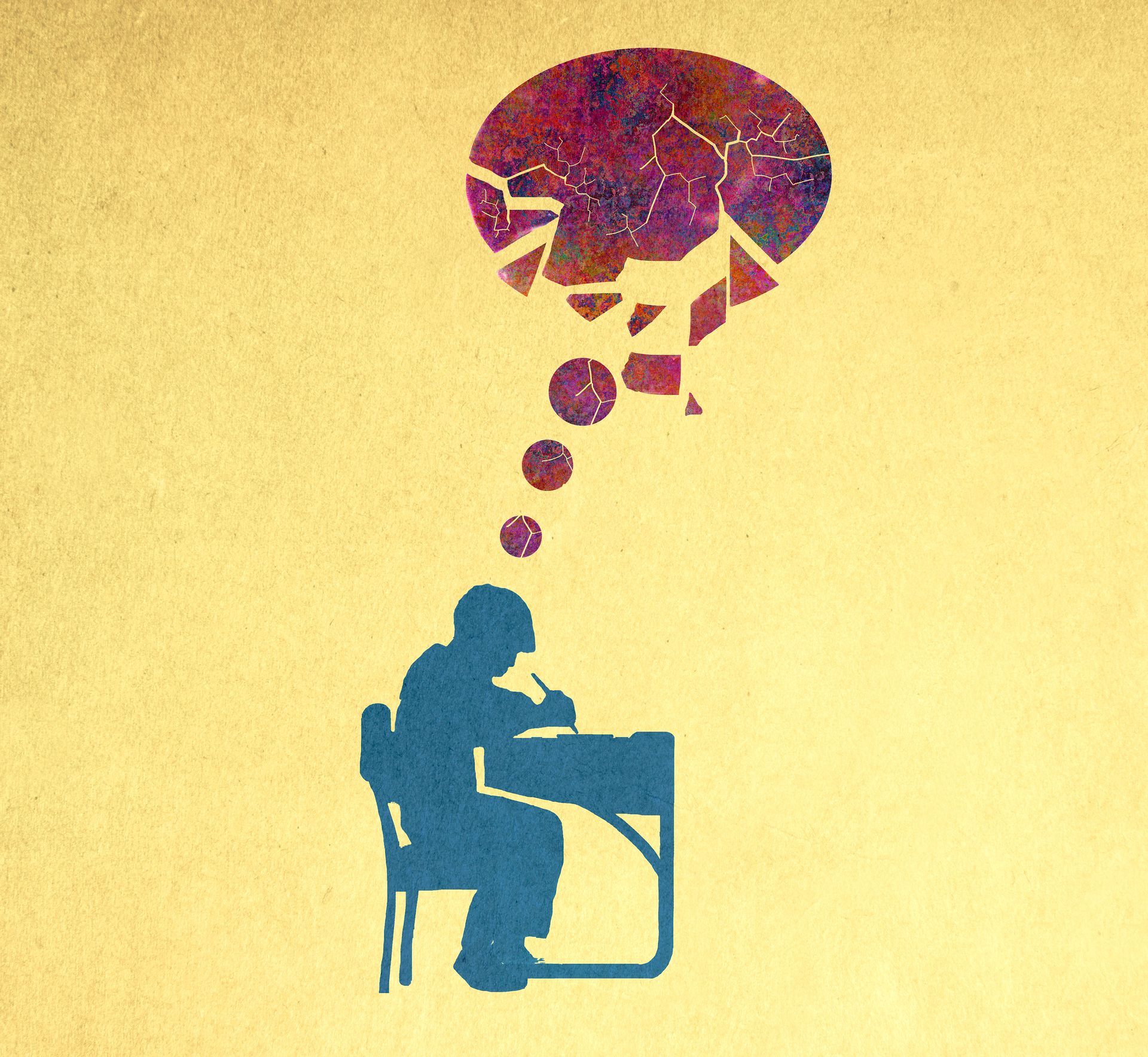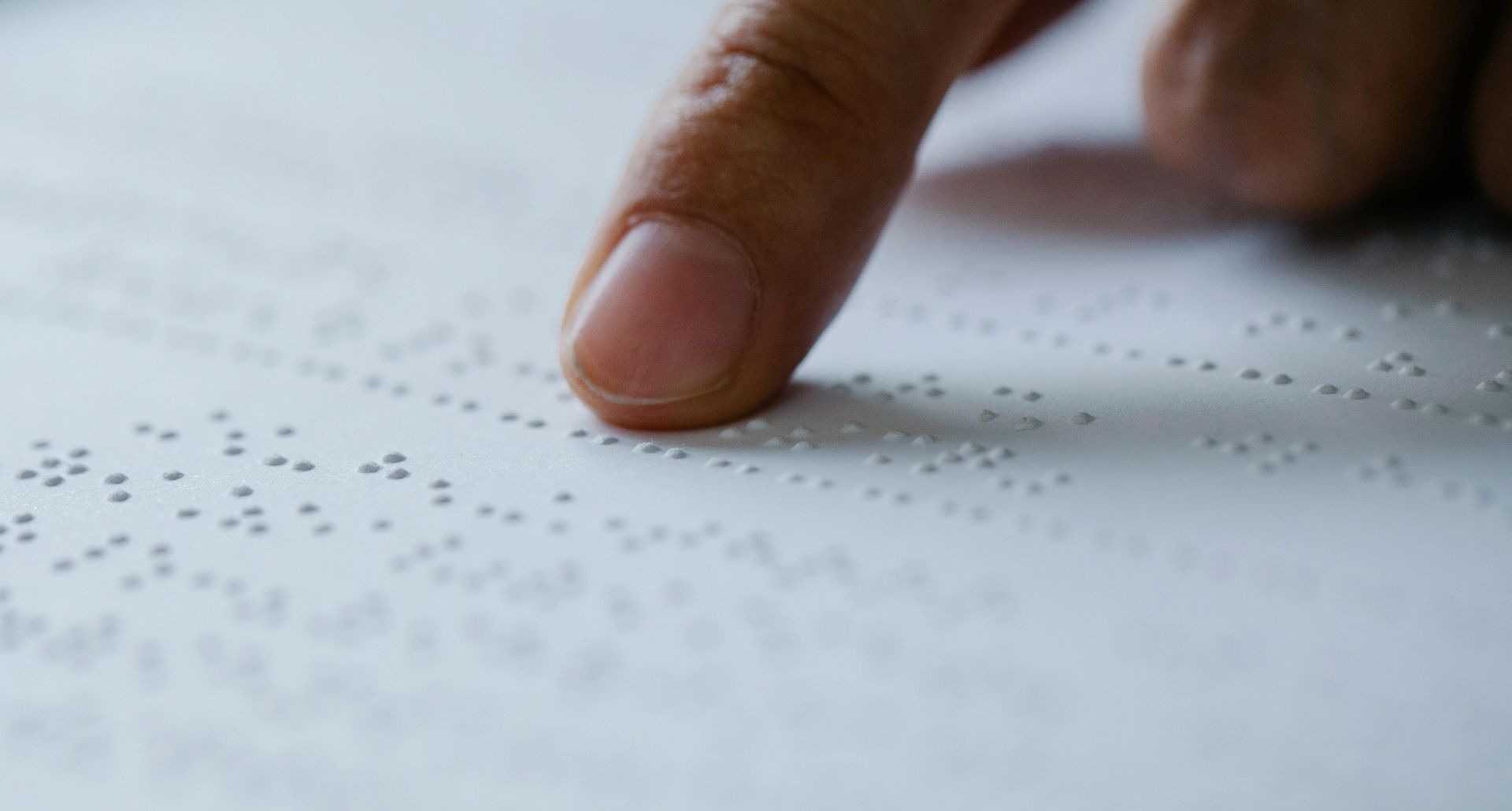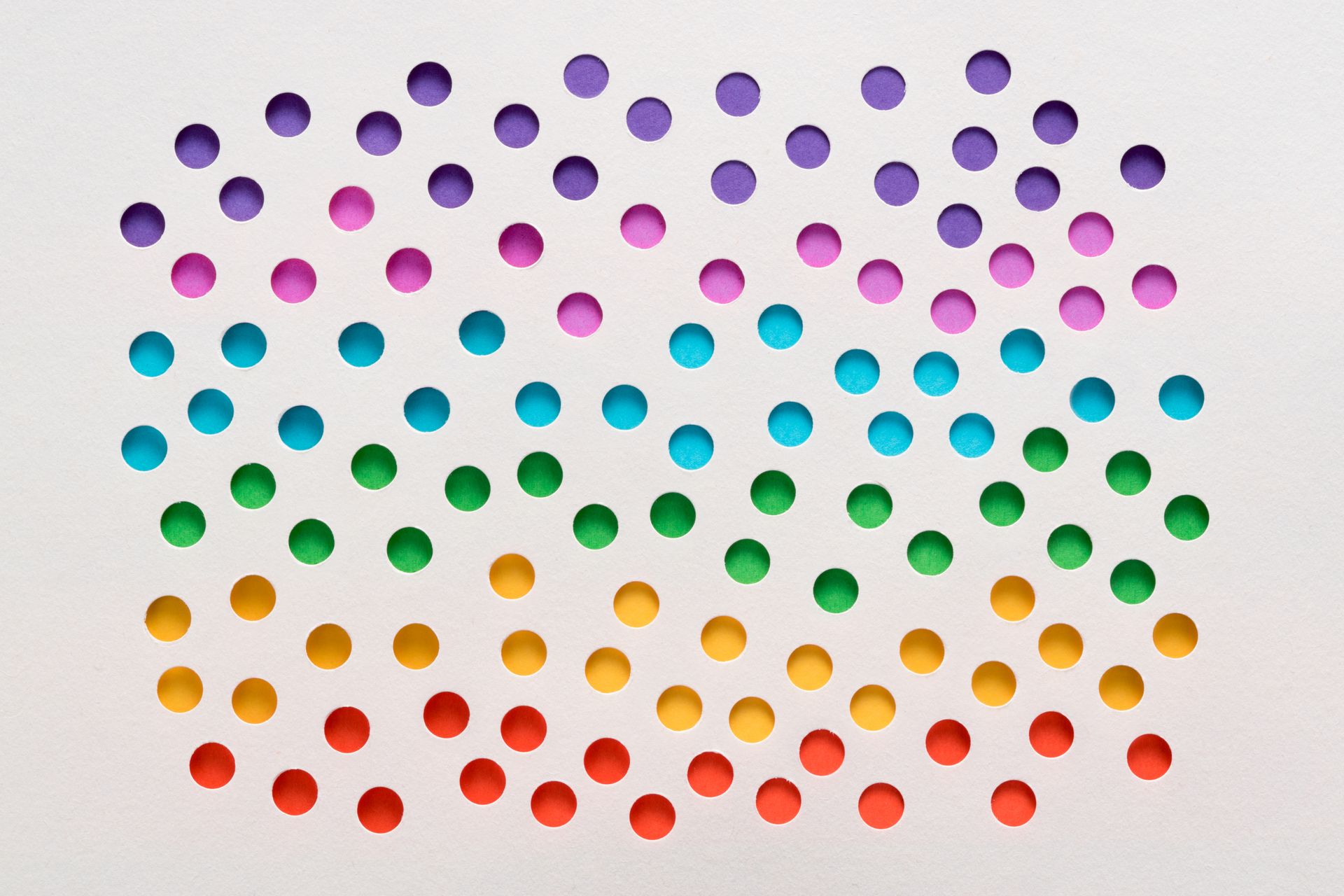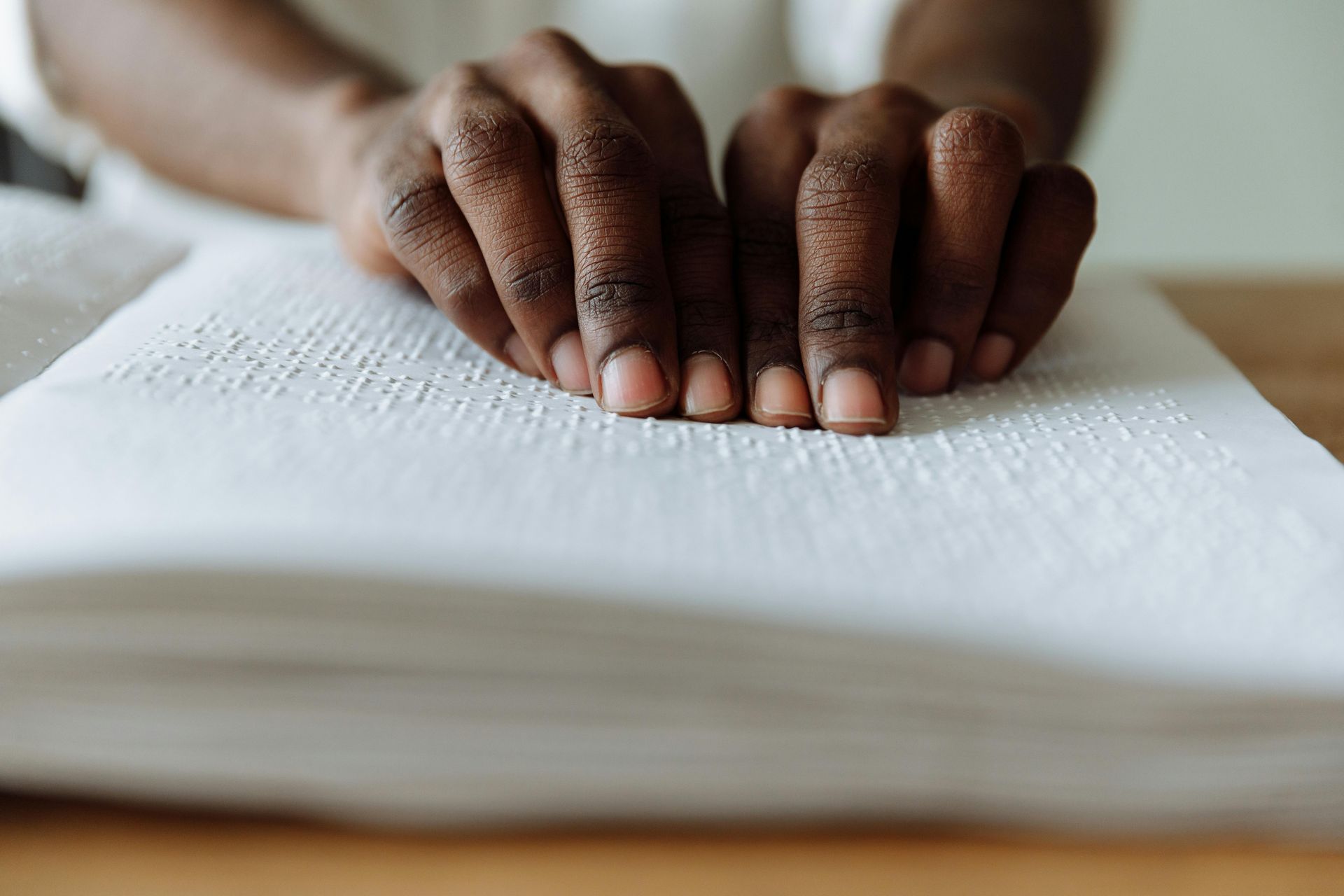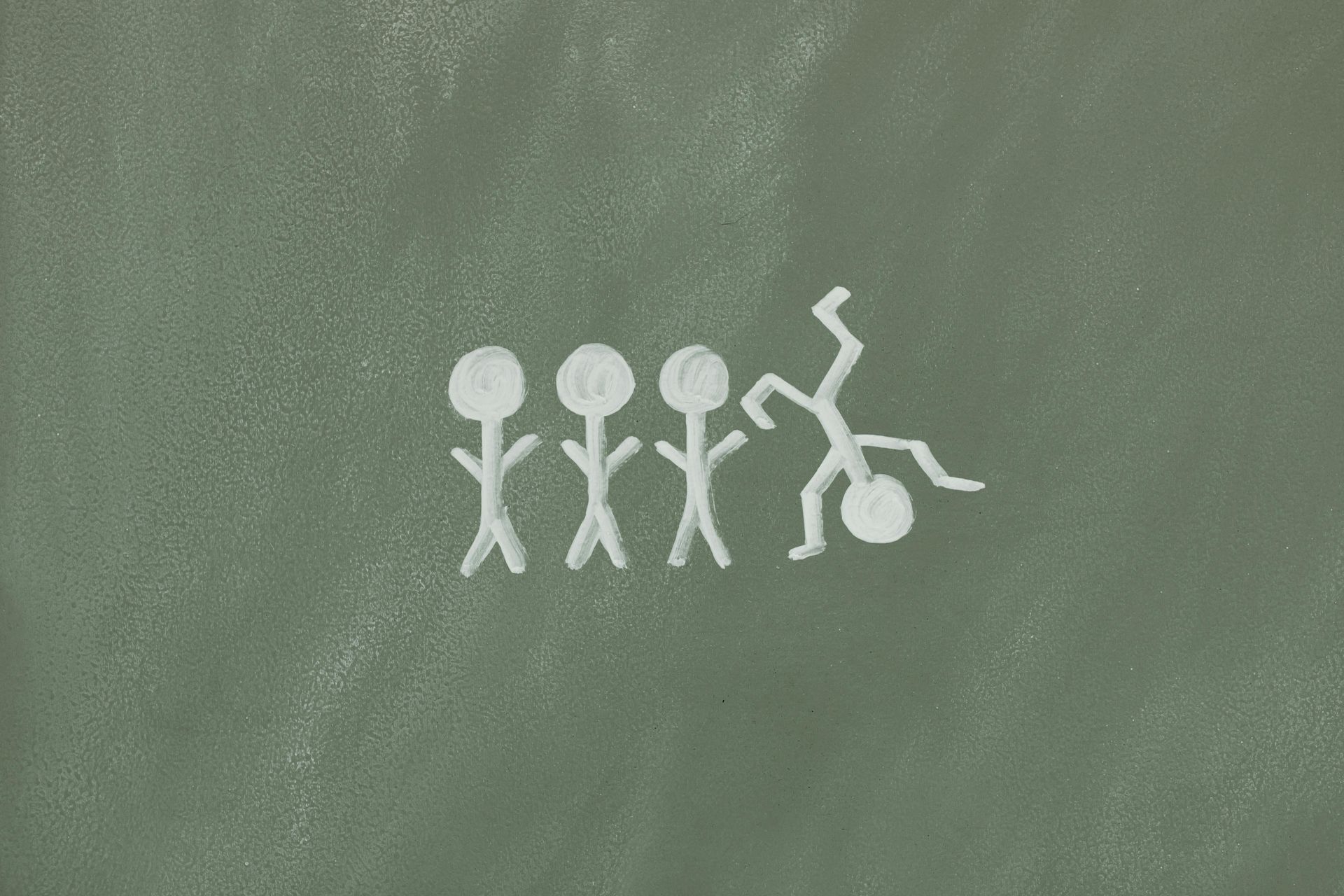Autore: Maria Luisa Gargiulo
•
7 marzo 2017
Riflessioni sulla comunicazione della diagnosi e la relazione genitore /figlioMolti genitori sentono come un problema importante quello che riguarda l’atteggiamento da avere nei riguardi dei loro figli, in merito a cosa e quanto comunicare, in caso il bambino abbia una malattia grave oppure una condizione che crea particolari svantaggi e disabilità. La comunicazione della diagnosi, specialmente se essa riguarda una condizione per la quale non esistono rimedi di guarigione, è sempre un momento molto difficile. È arduo per un medico giungere alla conclusione di non poter fare niente per sollevare una persona da un malanno che potrebbe essere causa una grave limitazione. È difficile per chi soffre, comprendere subito realmente il significato di una diagnosi di una malattia non guaribile. La frattura che si crea nella vita di una persona quando si imbatte in un evento traumatico di questo genere, come in una malattia, crea un effetto particolare. Da quel momento cambia completamente per la persona la percezione della situazione. È come se nulla fosse come prima. Sicuramente la comunicazione della diagnosi di una malattia grave è un evento importante da gestire. Comunicare non significa soltanto dare la notizia, bensì dovrebbe comportare anche aiutare attivamente la persona a comprendere e a disporsi nel modo migliore possibile nell’affrontare la nuova situazione. Questo non può avvenire in un momento solo, ma è un processo composto da varie fasi, con un andamento differente da persona a persona, che comporta quindi una evoluzione individuale. Questo si complica quando si ha a che fare con bambini, perché vi sono elementi di complessità che derivano dal fatto che occorre gestire sia la condizione del bambino stesso, sia la reazione alla diagnosi del genitore. A volte i genitori riflettono nuovamente sulla diagnosi e sulla definizione della condizione del loro bambino, nel momento in cui si pongono il proposito di comunicarlo al bambino stesso. È assolutamente legittimo per un genitore decidere quali siano i tempi, i modi e le informazioni che è giusto comunicare. Nessuno più di lui ha il diritto di scegliere queste cose. Sicuramente però può essere oggetto di molti dubbi e preoccupazioni per un genitore, pensare come e quando farlo, e a volte potrebbe servirgli chiedere sostegno e consiglio sul da farsi a persone da lui ritenute esperte. Spesso questa è l’occasione nella quale il genitore deve ripensare alla malattia del figlio ed alle sue conseguenze, perché si pone il problema di proteggere ed aiutare il bambino stesso a comprenderla, ad affrontarla, ad affrontare le altre persone che ne parlano oppure che gli chiedono. Il genitore si interroga se è possibile dare una descrizione comprensibile di questa condizione al bambino, e lo farà tanto più facilmente quanto più egli stesso avrà un atteggiamento chiaro e ben definito rispetto alla situazione del figlio. Di solito i genitori si pongono il problema di come presentare, come chiamare o come commentare la malattia, le cure, le conseguenze pratiche, perché sentono una difficoltà specifica nel farlo, e perché intuiscono che ciò potrebbe essere doloroso. Sicuramente questa attenzione e questo timore sono il segno che si tratta di un tema delicato, di un momento importante. A volte esiste qualche novità che utile chiarire, specialmente se vi è un cambiamento clinico, oppure un qualche evento da gestire, una nuova abitudine da assumere, un ricovero, alcune medicine, oppure nuovi oggetti o ausili che prima non facevano parte della vita del bambino. I cambiamenti e gli atti che riguardano il bambino e la sua famiglia dovrebbero essere annunciati e presentati, per consentire al bimbo di avere una rappresentazione sana e realistica di quello che sta succedendo, e per metterlo in condizioni di avere elementi di spiegazione e previsione di ciò che succederà in futuro. Il genitore comunica anche il proprio stato emotivo rispetto alle cose di cui parla o durante il proprio comportamento, e a volte quindi anche l’ansia, la rabbia o la disperazione che possono essere la sua comprensibile reazione alla situazione. Purtroppo a volte il bambino apprende implicitamente alcuni atteggiamenti, ad esempio impara a temere le visite mediche o alcune persone, a non riconoscere comportamenti che possono derivare dalla malattia, oppure a non collegarli ad essa, come se si trattasse di qualcosa di completamente scollegato. Sebbene comunicare alcune informazioni delicate ad un bambino possa essere sicuramente difficile, spesso potrebbe essere utile farlo, perché il dolore che il bimbo può provare è senz’altro minore del disagio prolungato e continuo che potrebbe avere nel vivere qualcosa che non comprende, che lo spaventa comunque (anche perché gli adulti gli sembrano spaventati), qualcosa che sembra far parte di un grande segreto che lo riguarda, ma che non riesce a cogliere. È senz’altro duro per un bambino comprendere di avere dei limiti, ad esempio capire di non poter fare alcune cose, oppure di poterne fare altre ma con modalità parzialmente differenti da quelle che usano i suoi compagni. È senz’altro utile per lui sapere che queste limitazioni non dipendono da una sua colpa o da una sua personale incapacità, ma che esse derivano da qualcosa che nessuno ha scelto e che non si può togliere. Le malattie non scelgono le persone, così come le persone non scelgono le malattie, quindi avere una malattia non significa essere stato più cattivo, meno furbo, più sbagliato, anzi siccome è più difficile fare le cose malgrado certi impedimenti, sicuramente quel bambino è molto più bravo degli altri, dato che riesce a fare alcune cose partendo da condizioni molto ardue. La sua situazione è molto più difficile da comprendere per il bambino, se egli non ha la possibilità di conoscere altre persone che hanno condizioni o problematiche simili alle proprie. È come se il bimbo vivesse essendo l’unico speciale, tra tanta gente che funziona in modo diverso da lui . invece, potersi confrontare con qualcuno che gli somiglia per qualche aspetto, consente al bambino di non sentirsi solo, lo aiuta nella lunga strada che lo porterà a distinguere la propria condizione patologica dai propri meriti o demeriti, dal rispetto e dalla stima che nutrirà verso se stesso. . Quindi conoscere persone che positivamente possono fungere da modelli, aiuterà il bambino ad acquisire nella propria identità personale le caratteristiche derivanti dalla limitazione o dagli impedimenti conseguenti, senza sentirsi completamente identificato nella patologia, in quanto anche altre persone, diverse e distinte da lui, hanno quella patologia o quelle caratteristiche, eppure non sono lui. Se si tratta di una condizione o di una minorazione che praticamente esiste da sempre, il bambino è più facilitato nell’inserire tale condizione nel quadro di una propria normalità. In questo caso la malattia e le sue conseguenze possono far parte di quel genere di cose “ordinarie”, ossia facenti parte direttamente dell’identità della persona, perché fanno parte del modo quotidiano di vivere se stessi e di affrontare le cose. Molto spesso alcuni bambini imparano a dedurre la loro condizione dai comportamenti degli adulti, oppure dalle parole di spiegazione dette sotto voce, che i gli adulti accennano in varie situazioni sociali o familiari. In questo senso, qualche volta, questi bambini, ai quali non si parla delle loro malattie per timore di svelare loro un doloroso segreto, pensano di essere loro stessi depositari di informazioni riservate, che non dicono ai genitori per timore di dare loro un dispiacere, o perché hanno imparato che di quell’argomento, evidentemente è bene non parlare. Non è quindi raro riscontrare situazioni familiari nelle quali ciascuno dei componenti, adulti e piccini, desidererebbe tanto trovare ascolto, supporto e condivisione, ma non lo fa per timore di ferire l’altro, oppure perché ha appreso in modo pratico, la regola che quell’argomento è da evitare. A volte celare la diagnosi o la spiegazione di una condizione patologica non protegge il bambino, bensì lo mette invece in condizione di correre alcuni rischi importanti, come quello di apprendere in modi negativi e dannosi da altre persone una definizione denigratoria della sua condizione o della sua malattia, oppure il rischio di perdere la fiducia nel genitore quando si accorge che egli gli nasconde qualcosa di importante che lo riguarda. Per il genitore provare fatica e difficoltà nel dover comunicare queste cose non significa che non ne sarà capace, ma è il segnale della consapevolezza di stare per affrontare un tema delicato ed importante. Pensare a come farlo è già un ottimo modo di cominciare. è importante che il genitore conosca i propri atteggiamenti e sentimenti rispetto ai temi che intende affrontare con il bambino, per evitare di comunicarli in modo inadeguato o involontariamente dannoso. Se il genitore sente la necessità, egli può parlare con suo figlio in presenza di un’altra persona, in caso questo lo faccia sentire più sicuro. è importante utilizzare parole semplici ma precise, in relazione all’età, alla personalità, alla maturità emotiva ed alle possibilità di comprensione del bambino. è importante predisporsi a comunicare in modo chiaro ma senza avere fretta di aggiungere dettagli e particolari, se non prima di aver verificato che il bambino abbia compreso tutto ciò che è stato detto fino a quel momento. Quando le cose di cui parlare potrebbero risultare complicate o significative, è importante fermarsi spesso, per accogliere le reazioni del bimbo. Esse possono andare dalla reazione emotiva più forte, fino l’evitamento più totale. È importante pensare che anche l’atteggiamento del bambino si snoda in un processo dinamico, che attraversa varie fasi e cambiamenti. Quindi, anche se a volte il bambino ci chiude la porta comunicando la sua indisponibilità a approfondire, è molto importante rispettare questo, e contemporaneamente lasciare sempre al bimbo una possibilità futura di continuare il discorso quando egli si sentirà di farlo. Ciò è molto importante, perché è frequentissimo riscontrare bambini molto interessati a temi che li riguardano, ma molto in difficoltà nell’affrontarli. Conseguentemente, questi bimbi tenderanno a voler sapere e capire, ad ascoltare ciò che li riguarda, anche senza che gli adulti se ne accorgano. Nonostante ciò, essi non sembrano sempre in condizioni di sostenere una conversazione in merito. Ciò è perfettamente naturale e non deve spaventare il genitore. Si tratta semplicemente del segnale che il bambino è interessato, ma allontanandosi, egli ci comunica di aver bisogno di tempo per elaborare emotivamente le informazioni che ha ottenuto su se stesso. È importante che egli sappia che può contare sugli adulti, quando vorrà riavvicinarsi per poter continuare a capire. In ogni caso, per quanto possibile, è sempre utile indicare al bambino una possibilità di affrontare le situazioni che gli si prospettano. Si dovrebbe poter indicare al bambino una maniera per gestire le cose. Anche quando non è possibile trovare una soluzione pratica agli eventi, è importante, dopo avere ascoltato e compreso i sentimenti del bambino, prospettare una soluzione emotiva. A volte compiere assieme delle azioni che per l’adulto potrebbero essere considerate puramente simboliche, potrebbe essere molto utile per il bambino, ad esempio conversare di un argomento delicato in compagnia di una bambola o di un orsacchiotto preferito dal bambino, chiudere una paura in una scatolina perché non torni a spaventarci nella notte, disegnare o giocare con dei burattini drammatizzando come si vorrebbe che andassero le cose, inventare assieme una canzone consolatoria da cantare nei momenti difficili, e mille altre azioni delicate e caldamente comprensive che rispecchiano le esigenze di quello specifico bambino.