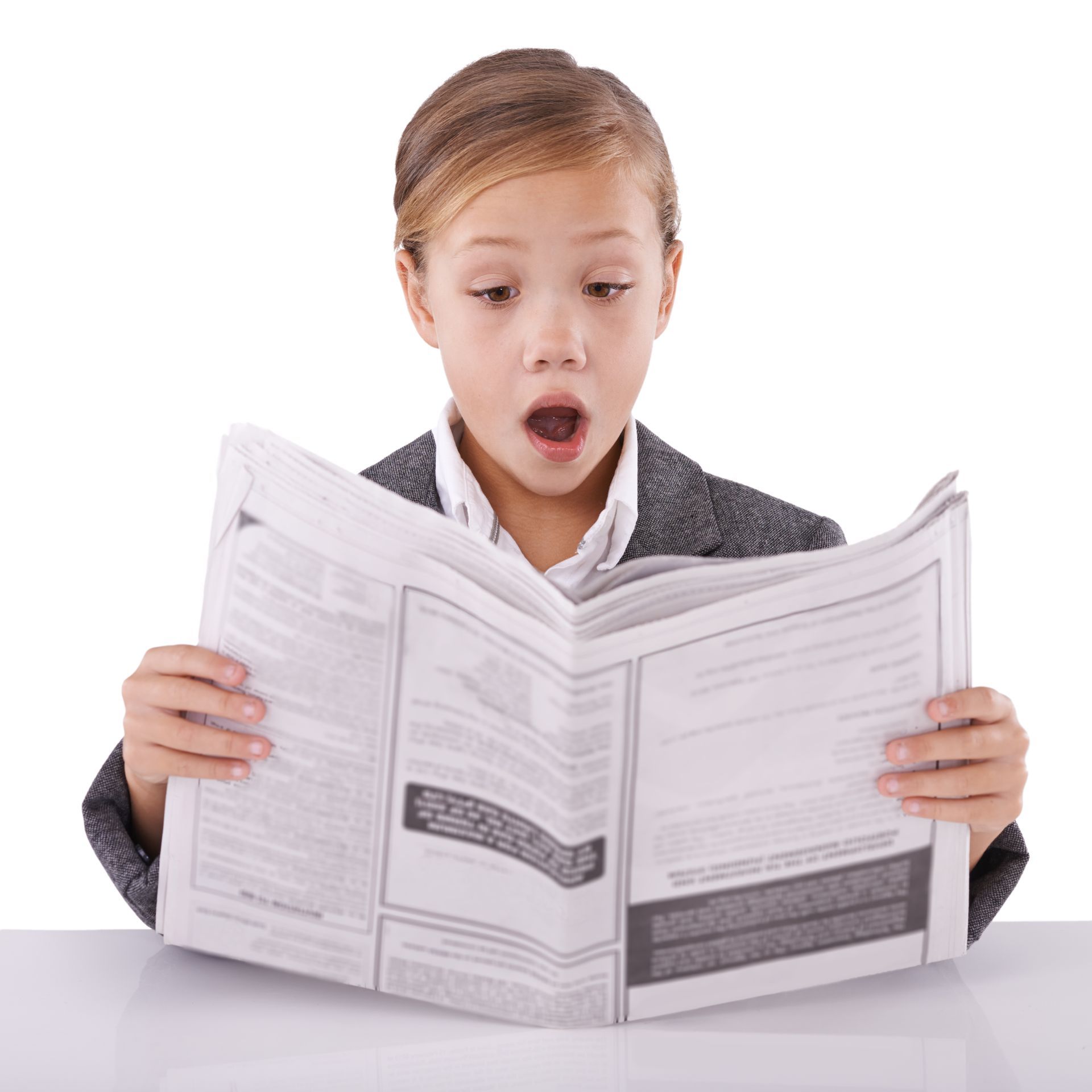Bambini e genitori
Essere genitori oggi significa affrontare sfide quotidiane che spesso richiedono ascolto, empatia e strumenti adeguati. Ogni bambino cresce con tempi, emozioni e bisogni propri, e ogni famiglia vive il proprio percorso tra gioie, dubbi e momenti di incertezza.
In questo spazio trovi articoli pensati per offrire spunti di riflessione, consigli pratici e approfondimenti psicologici su tematiche legate all’infanzia, all’adolescenza e alla genitorialità.
Dalla gestione delle emozioni alla relazione genitori-figli, dal comportamento a scuola ai cambiamenti evolutivi, l’obiettivo è accompagnarti nel comprendere meglio i segnali dei tuoi figli e sostenere il loro sviluppo in modo sereno e consapevole.

Autore: Maria Luisa Gargiulo
•
6 marzo 2020
Bambini e ragazzi in tempi di Coronavirus sono esposti a stress psicologico. L’atteggiamento concitato degli adulti, le informazioni continue sullo stesso tema, il cambiamento delle abitudini quotidiane, possono creare in loro disorientamento ed ansia. I piccoli assorbono le emozioni provenienti da noi adulti, specie quando non hanno informazioni chiare ed un adulto di riferimento rassicurante. Possiamo aiutarli dal punto di vista psicologico, proteggendoli dallo stress, ma consentendo loro di capire che cosa sta succedendo, per attuare il miglior comportamento possibile, insieme a noi.

Autore: Maria Luisa Gargiulo
•
28 febbraio 2019
In certi casi i genitori cercano alleanza nel figlio, specie quando vivono una situazione di alto conflitto relazionale o separazione . questo può causare un problema emotivo e psicologico nei bambini a causa della perdita emotiva che ne deriva per loro.

Autore: Maria Luisa Gargiulo
•
7 marzo 2017
Lo stupro della giovane che, in provincia di Salerno, è stata violentata da un gruppo di coetanei, ha suscitato indignazione, sgomento, paura e anche un dibattito su cosa si possa fare perché tutto ciò non accada mai più. Nelle ultime ore, oltre a parlare del fatto in sé, si stanno diffondendo sulla rete anche i commenti riguardanti le reazioni che le persone coinvolte hanno avuto, i loro familiari, le prese di posizioni degli opinionisti eccetera.Voglio dare il mio contributo, forse un pò fuori dal coro, dal punto di vista di chi come me si occupa per lavoro di salute psicologica delle persone e delle famiglie. Il trauma che questa ragazza dovrà superare, si profila come un’esperienza nella quale indubbiamente noi possiamo vederla solo come vittima e null’altro! A nulla valgono i tentativi di trovare in qualche modo una giustificazione, seppure lieve, seppur indiretta, una corresponsabilità della giovane non è sempre possibile, quando si conosce una nuova persona, accertarsi perfettamente che essa sia completamente affidabile. Questa ragazza non avrebbe potuto fare diversamente rispetto a ciò che ha fatto. Incutere paure nelle altre ragazze perché, dietro qualsiasi amico, si potrebbe celare uno stupratore, ci sembra abbastanza inutile, se non dannoso. Altra è la relazione duratura patologica, con una persona che si comporta in modo violento, minaccioso, malsano; relazione che ci può dare alcuni segnali di allarme, il suggerirci di allontanarci da quella persona prima che accada qualcosa di terribile. Ma in questo caso non è così, nulla faceva pensare tutto questo. Allora come possono le ragazze proteggersi da questo pericolo? La domanda è semplice ma la risposta esatta forse non esiste. Ma ci sono una serie di elementi, a mio avviso molto importanti che dovremmo sempre tenere presenti. Secondo me possiamo fare in modo che queste cose accadono sempre meno, agendo in più direzioni convergenti affinché questo pericolo diventi sempre minore. Credo che la questione debba essere affrontata riducendo la pericolosità degli uomini più che chiudendo a chiave le donne. E per farlo occorre agire su molti fronti. In questi giorni si sente parlare dell’inasprimento delle pene, della certezza della pena, del fatto che debbano essere utilizzate meno attenuanti quando i criminali vengono arrestati. Giustamente questo è un fattore che può agire come deterrente perché, sapere che quando si viene presi non si può farla franca, forse potrebbe influire. Purtroppo io non credo che questo sia un fattore sufficiente per diminuire significativamente questi orribili episodi. Quando si agisce una violenza del genere, si tengono raramente presenti le conseguenze. Se si fosse così saggi da ponderare il rischio della galera o di altri effetti, probabilmente si avrebbe anche la lucidità di non importunare, rapire, non stuprare. La salute psicologica degli uomini che agiscono in questo modo è radicalmente alla base di queste azioni. Nessun deterrente giudiziario può bilanciare una personalità problematica, emotivamente analfabeta, non in grado di gestire e modulare i propri bisogni, non in grado di capire che ciò che desidera non le sia dovuto automaticamente. Pochi anni fa quei ragazzi erano dei bambini. Come sono stati educati? In quale modo? Chi si occupa di loro? Quanto tempo hanno passato insieme a persone significative per riflettere e parlare dei desideri, dei bisogni del sesso, dell’amore, delle donne? Quali modelli hanno avuto? Come sono stati aiutati a superare lo sgomento, il vuoto di emozioni, la voglia di possesso che può senz’altro aggirarsi nell’animo di chiunque ma che, se non gestito, può trasformarsi in quello che noi abbiamo visto? Ho letto della reazione della zia di uno dei giovani: mio nipote è un bambino – e poi continuava alludendo all’unica sua passione la sua squadra di calcio del cuore. Lo sconcerto che ho provato mi sorge dalla riflessione che delle due l’una: o questa persona sta tentando in qualche modo di contribuire goffamente ad una strategia giudiziaria di difesa disperata peraltro legittima da parte degli avvocati del ragazzo ma che poi diventa una terribile farsa quando si trasforma in giustificazioni e negazioni così plateali, oppure questa persona davvero non conosceva suo nipote. In perfetta buona fede lo percepiva come una persona quieta, infantile, semplice, trasparente cristallina. Per passare a parlare del fenomeno e non più delle persone implicate, rifletto su quanta distanza mettiamo tra noi e i bambini, tra noi e gli adolescenti. Come le vediamo, attraverso quale filtro, quale l’ente che distorce e che annebbia per illuderci che siano i figli, i nipoti ideali che abbiamo sempre sognato. Che possiamo consolare giustificandoli, e non riuscendo a vedere nulla. Questa distanza però, contribuisce enormemente alla probabilità che queste persone diventino pericolose. Un ragazzo che dentro di sé ha un turbine di problemi, conflitti, bisogni mal espressi, inconfessate fantasie, inconfessabili progetti, di tutto può aver bisogno tranne che di gente che non riesce a vedere chi egli davvero sia. La costante sta nella minimizzazione di qualsiasi problema intra familiare, educativo emotivorelazionale che abbia solo un piccolo risvolto psicologico. Il giustificazionismo educativo al quale a volte mi pare di assistere ed in troppi contesti, non fa che allontanarci dal considerare la situazione per quella che è, cosa che è l’unica base di partenza per poi prendere gli opportuni provvedimenti per aiutare i nostri ragazzi. Giustificare tutto come forma di protezione del figlio, sarebbe come illudersi che la quiete apparente corrisponda al benessere reale. Quante volte gli insegnanti devono temere di parlare con i genitori di problemi scolastici perché si aspettano una reazione di difesa aprioristica, invece che una alleanza e collaborazione in favore della buona riuscita scolastica del ragazzo. Quante volte davanti a comportamenti che il genitore non si sente di poter comprendere né gestire, ci si trincera dietro un “passerà è l’età “, invece di consultare un professionista del benessere psicologico e della crescita? Quante volte la solitudine di un ragazzo è nascosta da trasporti interminabili tra i vari impegni pomeridiani che assolvono il genitore tassista, dalla difficoltà a comprendere e conoscere davvero quella persona ?… Quante volte giustifichiamo la nostra difficoltà a instaurare un dialogo con l’alibi dell’isolarsi del ragazzo con smartphone e simili protesi di una vita virtuale connessa? Le tante problematiche educative non devono mai trasformarsi in accuse generiche verso i genitori, che sono pur parte di un contesto sociale più ampio, il quale di certo non è di loro aiuto in tante occasioni. Quanto poco si investe nella prevenzione psicologica? Quanti istituti scolastici non hanno uno sportello psicologico? Quanti psicologi degli enti locali che vanno in pensione non sono sostituiti da nuovi colleghi a causa del blocco delle assunzioni e del taglio al sociale? Anche la psichiatria territoriale è in molte parti d’Italia in crisi organizzativa. Tante volte ci sono lunghe liste d’attesa per prendere in carico una persona in difficoltà e per forza maggiore ci si limita a gestire le emergenze più eclatanti. Eppure è oramai è noto che la prevenzione in tema di salute mentale, è alla lunga conveniente anche dal punto di vista economico, oltre che aumentare la qualità della vita e delle relazioni. Più si prevengono e si gestiscono situazioni problematiche, più si evitano costi altissimi successivi in termini di spesa sanitaria, di costo sociale, di dolore personale, comportamenti pericolosi, di altre vite spezzate o segnate per sempre. Ma un genitore per chiedere aiuto ad uno psicologo deve innanzitutto sapere cosa notare, essere disposto ad ammettere che c’è qualcosa che non va nella relazione educativa, conoscere i vantaggi di rivolgersi ad un professionista, sapere cosa e chi cercare, e poi poter pagare una o più parcelle, giacché spesso si tratta di un lavoro almeno a medio termine quasi tutto basato su prestazioni private. Non tutti hanno la fortuna di avere e saper fare tutto questo. Ed in questi casi, la nostra struttura sociale non garantisce che queste persone siano aiutate dall’esterno, prima ancora intercettate, accompagnate e seguite in modo efficace. Si tratta di un lavoro complesso, multifattoriale, che parte da un investimento serio innanzitutto economico oltre che culturale sulla protezione sociale del benessere psicologico. Ciò a partire dal sostegno alla genitorialità fragile, passando per la psicologia dell’educazione e quella scolastica, per arrivare ad agire sulle forme aggregative dell’età adolescenziale, epoca nella quale si formano e si consolidano i disturbi di personalità che, se non troviamo qualcuno che si prende carico del nostro inferno, ci portiamo poi per tutta la vita.

Autore: Maria Luisa Gargiulo
•
7 marzo 2017
Passeremo un certo numero di giorni assieme ai nostri bambini. Periodo di riposo, o tempo faticoso ? La scuola è finita da un pezzo, anche le iniziative estive di intrattenimento volgono al termine, come i centri estivi, le settimane al mare o in montagna organizzate da enti ed associazioni, eccetera. Ci accingiamo a trascorrere un periodo di maggiore contatto e vicinanza. Per alcuni può essere una opportunità, per altri un tempo difficile da gestire. Sicuramente l’estate è molto importante per la crescita e l’educazione dei figli, ed in generale, per il menage familiare. È spesso il termometro della situazione in cui siamo; finalmente tutti insieme, famiglia nucleare o ricomposta, con bambini che provengono magari da differenti matrimoni, o genitori divisi che fanno a turno per tenere i figli, oppure nonni da accudire in casa, ho da raggiungere fuori città. Tempo spensierato sotto l’ombrellone, o affannato a dividersi tra gli impegni moltiplicati causa ferie di badanti, tate, e collaboratori vari. Insomma, l’estate croce e delizia ! Un tempo tanto diverso da quello scolastico, così riconducibile ad una invernale normalità. Ma quali potenzialità offre questo periodo tanto atteso dai ragazzi, e qualche volta pieno di preoccupazioni organizzative per noi adulti? Innanzitutto, se abbiamo più tempo da trascorrere con i bambini, possiamo concederci di stare con loro, in una dimensione più rilassata, meno scandita dal via vai degli impegni settimanali. Il diradarsi delle attività dei figli, ci consente la possibilità di trascorrere del tempo con loro, senza la pressione dell’ennesimo impegno sulla tabella di marcia della giornata. Stare insieme senza la preoccupazione di dover fare in fretta le cose, per farle entrare tutte. In questa dimensione abbiamo forse un’occasione più unica che rara, di lasciarci andare alla fantasia, per sperimentare una dimensione di” compagnia”. Essere compagni dei propri figli e non solo autisti, finanziatori, controllori, mediatori, ci dà la possibilità di riscoprire una dimensione che una volta era propria della relazione tra gli adulti ed i piccoli: quella nella quale le persone tramandavano la conoscenza, raccontavano le storie della famiglia, provavano ad insegnare qualcosa di nuovo, trascorrevano il tempo mostrando ai bambini i propri interessi e chiedevano collaborazione nelle attività lavorative. Il genitore, infatti, ben lungi dalll’essere colui che si mette al servizio del “progetto figlio”, era qualcuno dal quale il figlio poteva apprendere, direttamente (ad esempio osservandolo nelle sue attività, o direttamente collaborando ed imparando), o oppure indirettamente (ascoltando, acquisendo informazioni sulla famiglia, le tradizioni, i luoghi e valori di appartenenza). Questo è un momento dalle grandi potenzialità di crescita per la relazione genitore bambino, oltre ad essere un importante strumento della “educazione informale ”, dimenticata al giorno d’oggi, Ma così necessaria nella crescita di tutti noi. Un’altra potenzialità è data dall’incontro estivo con coetanei, al di fuori del contesto scolastico. La trasformazione demografica della famiglia, costringe i nostri bambini a frequentare i loro coetanei, solo all’interno di istituzioni e strutture dedicate. La ricostruzione estiva, sia pur temporanea della famiglia allargata, consente alle persone delle diverse generazioni di riallacciare rapporti paritetici, e ricostituire le relazioni parallele che di inverno non abbiamo il tempo di coltivare. Così, frequentare cuginetti e amici di famiglia, consente ai bambini di sperimentare l’irrequieta palestra delle relazioni paritetiche, e diventare più capaci di cooperare, coalizzarsi, competere, organizzare, che sono capacità necessarie per la vita adulta. L’estate, e anche il tempo dei segreti, delle esperienze preadolescenziali al limite del raccontabile, della scoperta del corpo, così disponibile, svestito e libero da manierismi e formalità. Ma come spesso accade, emergono anche problemi. E così l’estate diviene spesso la lente di ingrandimento di grandi e piccole incomprensioni, disagi, difficoltà a gestire modi e tempi dell’educazione. Uno spazio ed un tempo che a volte sembrano troppo vuoti, in cui noi e loro, oltre a incontrarci, qualche volta ci ritroviamo a scontrarci. Una relazione da riallacciare, con questo strano individuo, che fino a qualche mese fa scarrozzavamo da una parte all’altra e con il quale ora troviamo poche cose da condividere. È il caso poi, dei genitori che fanno fatica a mantenere e consolidare le abitudini e le capacità di autonomia personale, raggiunte o in via di apprendimento, attraverso il lavoro di educatori e altro personale esterno alla famiglia. Quando queste persone sospendono il loro lavoro, qualche genitore potrebbe avere difficoltà a proseguire da solo, nel far continuare il cammino dell’autonomia ai propri figli. In effetti, ciò accade quando l’operatore educativo è stato delegato, oppure non ha lavorato per la generalizzazione ed il consolidamento delle abilità, all’interno delle normali attività familiari. In questi casi il bambino diviene dipendente dall’educatore, senza il quale egli sente la mancanza di una struttura normativa e di un contenitore emotivo. È il caso ad esempio, delle abitudini alimentari e delle abilità apprese nel mangiare, badare alla propria persona, acquisire un corretto ritmo sonno-veglia, eccetera. È molto importante ricordarsi che quando tutti questi traguardi non sono stati pienamente raggiunti, la sospensione estiva indiscriminata delle abitudini apprese, potrebbe essere causa di regresso nel percorso educativo. Così il bambino potrebbe perdere le abilità fin qui acquisite, ed a settembre, si dovrà ricominciare un passo prima, rispetto a dove si è lasciato a giugno. È senz’altro difficile mantenere un equilibrio tra la necessità di abbassare la tensione dal raggiungimento di traguardi- performance, per potersi dedicare ad un tempo di scoperta comunicazione, e la necessità di non mollare, sul fronte di alcuni obiettivi educativi non ancora consolidati. In entrambi i casi l’elemento fondamentale è il fatto che i ragazzi possano percepire chiaramente la nostra presenza e vicinanza: sentire che abbiamo voglia e siamo disposti a stare insieme, anche solo per ascoltarli o mostrare loro qualcosa. Insomma trasformiamo le vacanze in un momento per coltivare la relazione.

Autore: Maria Luisa Gargiulo
•
7 marzo 2017
Cercherò di rispondere a qualche domanda che concerne il rapporto tra lo psicologo, i ragazzi che egli segue ed i loro genitori. Spesso si creano alcune situazioni molto delicate, ed è importante sempre salvaguardare sia l’interesse della salute del minore, che l’autorevolezza del genitore, il quale comunque ha la responsabilità di quel bambino o ragazzo, se minorenne. Sicuramente per un professionista ottenere, meritare e conservare la fiducia dei genitori dei giovanissimi che egli segue è senz’altro qualcosa di molto prezioso ed importante. Quindi dal punto di vista morale, oltre che da quello giuridico, lo psicologo deve sempre tener presente che egli gode di una posizione assolutamente privilegiata, ossia quella di essere colui il quale viene talmente stimato e considerato da alcune persone, tanto che queste ultime gli affidano un figlio, cioè, presumibilmente qualcuno al quale costoro vogliono molto bene, e al quale, stanno cercando di dare un aiuto. Anche dal punto di vista legale, essendo i genitori detentori della potestà e responsabilità genitoriale, essi devono poter decidere e sapere tutto quanto sia utile per prendere le migliori decisioni in favore dei loro figli. Infine, sotto il profilo economico, i genitori sovente sono coloro i quali pagano il costo delle sedute, e quindi, sono parte attiva del contratto stipulato con il professionista. D’altro canto, vi sono anche interessi ed accortezze riguardanti la relazione tra il professionista ed il minore, che devono essere tenute presenti proprio per garantire il miglior livello di alleanza terapeutica e di fiducia possibile, al fine di costruire le condizioni più favorevoli per aiutarlo pienamente. In qualsiasi relazione di cura, e particolarmente nella relazione tra un paziente ed uno psicologo psicoterapeuta, assume una importanza enorme la qualità della relazione che si instaura tra le due persone. Questo aspetto non è una piacevole e casuale conseguenza di un incontro felice, bensì è una vera e propria modalità di lavoro, perché quel professionista, muovendosi nell’ambito psicologico, si trova ad utilizzare elementi come il clima, la motivazione, l’alleanza, e molte altre variabili interpersonali ed emotive, come veri e propri strumenti di lavoro. Talvolta una buona relazione tra le persone, è il prerequisito necessario per poter avviare un lavoro fruttuoso. Quindi, con gli adulti così come con gli adolescenti e con i bambini, gli aspetti concernenti la relazione tra il professionista ed il suo paziente, sono comunque condizioni molto rilevanti. Per questo motivo, il professionista che lavora con dei minori, deve talvolta contemperare il bisogno di rendere conto ai loro genitori del lavoro che sta portando avanti, con la necessità di tutelare la riservatezza della persona, e conseguentemente preservare una qualità relazionale compatibile con il suo lavoro. Qualche volta mantenere questo equilibrio è piuttosto facile, specialmente se i genitori sono già informati, oppure se hanno avuto precedenti esperienze, dirette o mediate attraverso l’esempio o il racconto di qualche altra persona. Altre volte, invece, è comprensibile che i genitori siano abbastanza dubbiosi su cosa sia meglio fare o non fare, chiedere o meno, intervenire, domandare chiarimenti al terapeuta, se si,in che modo eccetera. D’altra parte anche il professionista in certi momenti deve poter bilanciare due legittime esigenze, tutte due da prendere in seria considerazione, quella di non essere visto dai genitori come qualcuno che svolge misteriose ed incontrollabili azioni con il loro figlio, e dall’altra,quella di non essere scambiato dal ragazzo come colui il quale, emissario dei genitori, non fa altro che, pagato, agire per loro conto. In realtà lo psicologo non è né l’una nell’altra cosa, e deve tenere presente sempre, come massimo interesse, il benessere psicofisico del minore ed il suo miglior rapporto possibile con i genitori.

Autore: Maria Luisa Gargiulo
•
7 marzo 2017
A seguito di alcune richieste pervenutemi, inserisco qui alcune notizie sulla teoria dell’attacamento. Il sistema dell’attaccamento fa parte dei Sistemi Motivazionali Interpersonali (SMI), che comprendono anche il sistema dell’accudimento, del rango (o competitivo), quello cooperativo paritetico e quello sessuale. Gli SMI possono essere considerati come principi organizzatori a base innata, che regolano il comportamento sociale. Ciascuno di essi è osservabile attraverso precisi comportamenti che sono attuati per il raggiungimento di una meta. Ciascun sistema si attiva in presenza di condizioni specifiche ed è caratterizzato da segnali non verbali, con i quali gli individui comunicano le loro intenzioni ai membri della stessa specie. Ciascuno SMI è contraddistinto dalla comparsa di specifiche emozioni. In particolare, il sistema dell’attaccamento regola il comportamento di ricerca di protezione. Si attiva nelle situazioni di fatica, dolore fisico o emozionale, solitudine, minaccia, paura, disagi corporei. Il suo principale segnale di attivazione è il pianto. La meta consiste nel cercare la vicinanza protettiva di un conspecifico, attraverso l’attivazione del suo complementare sistema di accudimento. Dal punto di vista emozionale, l’attivazione del sistema di attaccamento è contraddistinta dalla paura da separazione, da rabbia e protesta. All’ottenimento della vicinanza protettiva, le emozioni conseguenti sono conforto, gioia e, successivamente, sicurezza. A questo punto il sistema dell’attaccamento si disattiva, per lasciare spazio generalmente a comportamenti di esplorazione o gioco sociale. Se la meta non viene raggiunta, le conseguenti emozioni sono tristezza, rabbia, disperazione ed infine distacco emozionale. Si intende per relazione di attaccamento quella con una Figura di Attaccamento (spesso abbreviata in FdA), persona dalla quale ci si aspetta cura e vicinanza protettiva. Generalmente si tratta quindi dell’individuo ritenuto dal bambino più determinante per la sua sopravvivenza e la sua difesa. Il modo con il quale la FdA risponde ricorsivamente alle richieste del bambino di cura e vicinanza protettiva, determina una aspettativa rispetto al suo comportamento futuro, alla risolvibilità nella situazione problematica, alla consolabilità del dolore o della paura che il bambino prova. La ricerca scientifica sull’attaccamento è partita dallo studio del legame precoce genitore-bambino, e fornisce una cornice di riferimento per comprendere il modo in cui una qualità adeguata della funzione genitoriale, associata a condizioni di sicurezza emotiva nel contesto sociale del bambino, ne favorisce lo sviluppo. John Bowlby, dal 1942, inaugurò una nuova stagione dello studio psicoanalitico del bambino e della famiglia. L’Autore fu tra i primi a utilizzare la teoria generale dei sistemi in alternativa alla teoria metapsicologica. Il contributo di Bowlby verrà ripreso e utilizzato successivamente anche da psicoterapeuti della famiglia e da terapeuti cognitivi. In seguito si sono sviluppati ampi settori di connessione con le teorie etologiche, in quanto il comportamento di attaccamento viene studiato anche da un versante evoluzionistico. Determinanti per la ricerca sono stati gli apporti di Mary Ainsworth, che negli anni 60 ha iniziato a osservare il comportamento di bambini con le loro madri, attraverso l’utilizzo sempre più raffinato di uno strumento di osservazione chiamato “Strange situation”1. Le ricerche di Mary Main hanno indagato l’attaccamento nell’adulto, attraverso L’Adult Attachment Interview2. I raffronti tra i dati riguardanti i bambini e quelli degli adulti hanno comprovato l’esistenza di correlazioni significative tra gli stili di attaccamento del bambino ed i rispettivi atteggiamenti e rappresentazioni dell’attacamento dell’adulto. Vengono attualmente classificati 4 diversi modelli o stili di attaccamento del bambino, in relazione ad altrettante reazioni ricorrenti del genitore alla richiesta di cura. Inizialmente si osservarono tre stili organizzati di attaccamento, denominati Sicuro, Insicuro Evitante e Insicuro Resistente. Successivamente ne è stato individuato un ulteriore, detto Disorientato/Disorganizzato, che sembra prodursi in concomitanza con reazioni del genitore caratterizzate da spavento, angoscia, dissociazione, o dall’innescarsi in lui di reazioni emotive derivanti da altri sistemi motivazionali oltre a quello dell’accudimento (di attaccamento, agonistico, sessuale, ecc.). Tali modelli precoci, sebbene possano essere modificabili da eventi significativi successivi, sembrano relativamente stabili. Inoltre esistono specifici studi sugli stili di attaccamento relativi alla madre ed al padre, ed alle influenze degli stili di attaccamento del partner nell’ambito di una coppia. Attualmente la ricerca sull’attaccamento si è estesa allo studio della psicopatologia, grazie ai significativi contributi di Peter Fonagy, Giovanni Liotti, Marsha Linehan ed altri. L’interesse si è focalizzato sulla correlazione tra particolari stili di attaccamento e stati mentali, che caratterizzano alcuni disturbi. In particolare sono note specifiche strategie di controllo3, derivanti da quelle che il bambino mette in atto per gestire e dare significato alla propria esperienza nei confronti di un genitore spaventato e quindi destabilizzante. Inoltre, è noto come alcuni stati di coscienza alterati caratteristici della dissociazione nelle sue varie forme, sono correlabili con il disorientamento e la perdita delle capacità riflessive, tipici della disorganizzazione dell’attaccamento. La ricerca scientifica sembra quindi sempre più confermare che l’attaccamento disorganizzato è altamente correlato all’insorgenza di problemi psicologici.

Autore: Maria Luisa Gargiulo
•
7 marzo 2017
Un bambino che mangia abitualmente più di quanto dovrebbe alimenti non salubri, rischia di sviluppare un attaccamento al cibo che denota malessere psicologico e può diventare un adulto con problemi cardiovascolari, con alta probabilità di contrarre svariate malattie, che incidono pesantemente sulla qualità della vita.