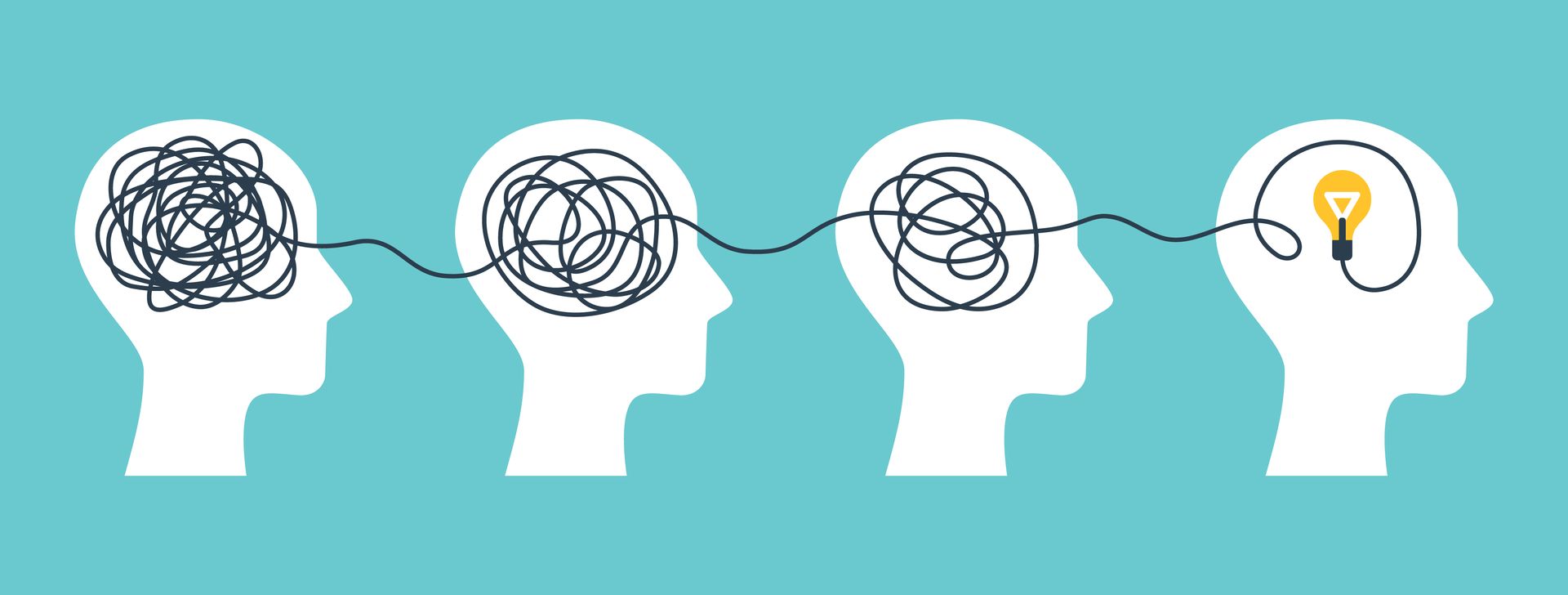Creare facilitatori ambientali
Progettare facilitatori ambientali efficaci per un disabile visivo
Relazione al corso ” percepire casa mia ” del 22 novembre 2014
Dott.ssa Maria Luisa Gargiulo
Analizzare le caratteristiche del processo di orientamento, conoscenza e movimento di un disabile visivo e le sue esigenze di fruizione ambientale, sono i primi elementi per poter riconoscere e valorizzare gli indizi esistenti negli ambienti, nonché per progettare facilitatori ambientali efficaci. Occorre partire dalla considerazione che in ogni ca¬so dall’ambiente si possono continuamente trarre informazioni attraversotutte le modalità sensoriali. È quindi possibile disseminare l’ambiente fisico di elementi capaci di dare appropriate informazioni, anche non appartenenti al canale visivo, per poter consentire alle persone non vedenti ed ipovedenti di svolgere ugualmente il loro processo di orientamento. Sarà comunque molto importante evitare di inserire troppe informazioni e tra loro fuorvianti, per evitare di indurre la persona ad inutili distrazioni.
Qui di seguito sono genericamente elencate alcune caratteristiche ambientali utilizzabili per valutare e migliorare gli spazi di vita del bambino, come la cameretta e gli altri ambienti della casa, o gli ambienti scolastici, come l’aula, la mensa, la palestra, i laboratori. Questi criteri dovrebbero essere utilizzati anche per progettare e realizzare le stanze adibite ad attività riabi¬litative ed educative, e ogni altro ambiente in cui desideriamo che la persona possa fare a meno della mediazione dell’adulto per relazionarsi con gli oggetti e con lo spazio.
Alcune caratteristiche qui indicate si riferiscono ad aspetti non visivi, come particolarità tattili o acustiche. Mi preme sottolineare che questi fattori di facilitazione sono utili tanto per le persone ipovedenti quanto per quelle che non vedono. Altri aspetti, specificamente attinenti a caratteristiche visi¬ve inerenti alla luce, ai contrasti, ai colori ecc, possono essere utilmente considerati per aumentare la visibilità ed il comfort, in particolare delle per¬sone con vista bassa.
- La persona con deficit visivo può usare informazioni acustiche ambienta¬li per l’orientamento e la deambulazione. Inoltre, anche durante l’ese¬cuzione di compiti che non prevedono lo spostamento, la concentrazio¬ne ed il livello di ansia potrebbero essere comunque condizionati dal ru¬more di fondo. Anche la comunicazione verbale è senz’altro più difficile in presenza di stimoli uditivi disturbanti. Quindi le caratteristi¬che acustiche di un ambiente sono molto importanti. Le proprietà acu¬stiche dei materiali e le dimensioni degli ambienti ne determinano il li¬vello e la qualità sonora. È difficile concentrarsi in luoghi con un rumore di fondo molto alto, quali mense affollate o ambienti chiassosi di vario genere. Se il rumore di fondo non può essere abbassato, sarebbe op¬portuno dotare il locale di materiali fonoassorbenti, che contribuiscano a limitare la diffusione e la riflessione dei suoni. Ciò è anche molto impor¬tante in presenza di ambienti grandi e relativamente vuoti, nei quali i rumori vengono riverberati ed amplificati da riflessioni acustiche che si aggiungono alle fonti primarie di rumore. Qualora sia necessario utiliz¬zare locali con queste caratteristiche, si dovrebbe preferire di posiziona¬re la persona in prossimità di angoli o pareti, in modo da limitare l’abbagliamento acustico.
- La forma degli ambienti può facilitare l’orientamento se è regolare e possiede angoli a 90°. Ciò perché una rotazione di 90° è più riconoscibi¬le percettivamente rispetto a qualsiasi altra ed è più facile comprendere e ricostruire il proprio orientamento rispetto all’ambiente dopo averla compiuta. Infat¬ti, è difficile effettuare con consapevolezza rotazioni differenti, senza punti di riferimento visivi. La forma regolare determina inoltre una mag¬giore memorizzabilità dell’ambiente, elemento da tener sempre pre¬sente anche nella dislocazione dei vari mobili e suppellettili e nel loro numero.
- Altra condizione importante è quella della raggiungibilità: se ciascun elemento può essere toccato, esso viene conosciuto. La collocazione di elementi potenzialmente significativi ad altezze ed in posizioni che li rendono non facilmente avvicinabili, sarebbe assolutamente da sconsi¬gliare. Questo sia perché la raggiungibilità consente al bambino un’e¬splorazione tattile agevole, sia perché, in presenza di ipovisione, la pos¬sibilità di avvicinarsi molto ai singoli elementi per poterli guardare da vicino, ne determina una maggiore fruibilità visiva.
- La riduzione nella quantità degli oggetti, oltre ad aumentare la memo¬rizzabilità degli elementi e delle posizioni, può essere un fattore di faci¬litazione della creazione di mappe mentali. La loro dislocazione ordinata e schematica determina anche una più agevole percezione visiva. Co¬me si può facilmente intuire, un ambiente troppo pieno è anche un am¬biente visivamente affollato, con caratteristiche che possono dar luogo ad immagini confuse. Ciò può determinare una significativa difficoltà nell’individuare e riconoscere i singoli oggetti.
- L’ambiente dovrebbe essere concepito con criteri di comfort visivo, basato su di un buon contrasto cromatico e specialmente di luminanza, tra i vari elementi architettonici. Lo stesso criterio si dovrebbe usare per gli elementi significativi per l’orientamento, quali porte, maniglie, in¬terruttori, finestre e per gli eventuali ostacoli e gli altri elementi da enfa¬tizzare, quali pilastri, spigoli vivi, colonne ecc.
- Dovrebbero essere banditi elementi visivi di disturbo, cioè motivi e sfondi articolati che non abbiano un valore funzionale o che non ricon¬ducano ad oggetti reali. Ciò perché è possibile che elementi visivi pura¬mente virtuali possano essere confusi con oggetti reali. Quindi sono da evitare tappeti, rivestimenti o tappezzerie che contengano fantasie o immagini di sfondo.
- Si dovrebbero utilizzare il meno possibile superfici lucide e specchiate, per evitare riflessi e abbagliamento.
- L’illuminazione nelle stanze che potrebbero essere usate da persone ipovedente, dovrebbe essere personalizzabile e quindi variabile per intensità, per compensare problemi di abbagliamento o di scarsa accomodazione alla luce. Dovrebbero essere inoltre disponibili anche il¬luminatori spot, ad intensità variabile, per oggetti da illuminare singolar¬mente, secondo le necessità personali, ad esempio contro un fondo bu¬io, facendo attenzione che la luce diretta non capiti mai sul viso del bambino. Per la scelta della migliore situazione di illuminamento, si do¬vrebbero seguire le indicazioni dei clinici che conoscono le necessità specifiche del bambino. Si dovrebbe fare molta attenzione affinché le fonti di luce naturale o arti¬ficiale non siano collocate in modo tale da proiettare ombre in corri¬spondenza dei punti e degli oggetti che il bambino deve osservare.
- Gli spazi che il bambino ipovedente può percorrere in autonomia, all’e¬sterno ed all’interno dei singoli locali, dovrebbero possedere una certa uniformità di illuminamento. Questo vale per gli ambienti illuminati unicamente da luce artificiale, oppure di sera o quando il cielo è partico¬larmente annuvolato. Se anche alla luce del giorno l’ambiente presenta zone quasi buie, marcatamente contrastanti con spazi più illuminati, si dovrebbe badare a compensare queste differenze, schermando par¬zialmente le zone troppo illuminate e collocando luci artificiali nelle zone più buie.
- Si dovrebbero tener presenti accorgimenti atti ad evitare possibili fonti di pericolo; tra queste ultime sono specificamente da evitare elementi aggettanti, ossia quelli che posseggono un ingombro che si interrompe ad una certa altezza e non prosegue fino al pavimento. Questi tipi di og¬getti sono una barriera percettiva molto pericolosa perché, non potendo essere intercettati adeguatamente, possono colpire il capo del bambino, senza che egli abbia la possibilità di accorgersi anticipatamente, con gli arti o con il bastone, della loro presenza.
- Sarebbero anche da evitare corrimani di scale che inizino dopo il primo gradino o terminino prima dell’ultimo. Dal punto di vista visivo, le scale dovrebbero essere illuminate in modo tale per cui, dal basso, la pedata e l’alzata abbiano una marcata differenza di luci ed ombre. Le scale, os¬servate dall’alto, dovrebbero possedere elementi marcagradino di colo¬re molto contrastato rispetto al colore della pedata. Un segnale rilevabile dal senso tattile plantare dovrebbe essere posto sul pavimento prima del ciglio del primo gradino in discesa.
- La riconoscibilità dei luoghi e degli elementi salienti, utili all’orientamento e allo spostamento del bambino, dovrebbe poter essere agevolata an¬che dalla collocazione di punti di riferimento specifici. A vantaggio dei bambini che posseggono esclusivamente un livello oggettuale della comunicazione e non hanno accesso al linguaggio scritto, e di tutti gli altri che si desidera facilitare in qualche modo, si possono u¬tilizzare piccoli simboli per marcare maniglie, porte, cassetti o qualsiasi altro elemento che si voglia ben distinguere da altri, e che non sia rico¬noscibile esclusivamente dalla sua forma o posizione
- È possibile ottimizzare gli amienti e talvolta per farlo, occorrono poche modifiche, che però risulteranno importanti e spesso determinanti rispetto al confort e alla consapevolezza del bambino di vivere da protagonista la propria casa, l’aula e gli alttri spazi per lui significativi.
- Per indicare quali siano le modifiche necessarie occorre svolgere una analisi percettiva che è alla base di qualsiasi valutazione specifica. Ciò è possibile attraverso 4 passi principali :
- capire con i genitori cosa desiderano ottenere, quali sono le funzioni degli ambienti e quale è il livello attuale di autonomia del bambino.
- svolgere un sopralluogo in cui si possa analizzare le criticità percettive degli ambienti ed i punti di forza
- acquisire informazioni o valutare direttamente le necessità ed i limiti funzionali del bambino in questione
- indicare soluzioni di facilitazione ambientale per ottimizzare l’ambiente.